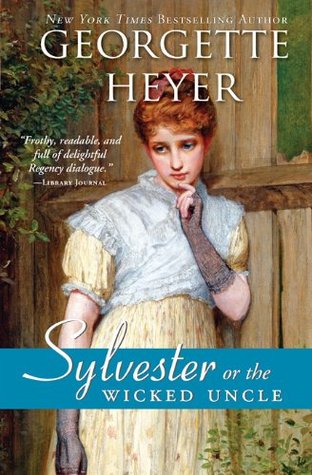Come detto nell’articolo precedente, si può dire che abbia letto The Mystery of Edwin Drood di Dickens solo perché non volevo arrivare “impreparata” alla lettura di Drood: come si capisce fin dal titolo, infatti, il romanzo di Simmons si ispira (vagamente) alle atmosfere del classico dickensiano incompiuto, e io volevo essere in grado di cogliere tutti i riferimenti e le citazioni nascoste per rendere la lettura ancora più “gustosa”. Insomma, il libro di Simmons era quello che mi “importava” di più, da cui mi aspettavo di più.
Come detto nell’articolo precedente, si può dire che abbia letto The Mystery of Edwin Drood di Dickens solo perché non volevo arrivare “impreparata” alla lettura di Drood: come si capisce fin dal titolo, infatti, il romanzo di Simmons si ispira (vagamente) alle atmosfere del classico dickensiano incompiuto, e io volevo essere in grado di cogliere tutti i riferimenti e le citazioni nascoste per rendere la lettura ancora più “gustosa”. Insomma, il libro di Simmons era quello che mi “importava” di più, da cui mi aspettavo di più.
Col senno di poi non era neanche necessario “prepararsi” tanto; anzi, vediamola così, almeno tutto ciò mi ha fornito il pretesto per leggere il libro di Dickens, che si è rivelato gradevole. Potevo fermarmi lì e non leggere questo.
Se qualcuno volesse mettersi a leggere Drood (ma anche no), sappia che se non ne ha voglia può anche risparmiarsi questa operazione preliminare: questo non è un tentativo di scrivere il finale del romanzo rimasto incompiuto, ci sono sì dei riferimenti qua e là, tornano alcuni nomi (a cominciare da quello di Drood, ovviamente, ma che non ha nulla a che fare col Drood immaginato da Dickens), ma se non si conosce la trama del primo libro non si perde nulla.
In breve: Drood di Simmons per me è stato un fallimento quasi totale. E purtroppo sono più di 800 pagine: quando non ho più potuto nascondere a me stessa che il libro non mi stava piacendo per nulla ero già arrivata a pagina 400 circa, e a quel punto (e visto che il libro me lo sono proprio comprato, forse sono stata attratta dalla bellissima copertina) ho pensato fosse più sensato farsi forza fino alla fine.
Leggo sul retro del libro che secondo il Daily Telegraph “le pagine scorrono via come se avessero le ali”. AHAHAHAHAHAH. Forse le prime 100, che effettivamente hanno un avvio promettente (tutto ha origine – non è uno spoiler – da un incidente ferroviario in cui rimane coinvolto Dickens, che da allora inizia a essere “perseguitato” da una strana figura dall’aspetto demoniaco di nome Drood: per scoprire chi sia e cosa voglia da lui lo scrittore coinvolge il suo collega/amico/rivale Wilkie Collins, la voce narrante del libro), ma siccome quasi subito il libro abbandona le atmosfere di inquietante mistero tuffandosi in un inverosimile tour dei sotterranei di Londra, fra catacombe e templi egizi (mi ha ricordato molto Indiana Jones e l’ultima crociata), il lettore perplesso si chiede come si potrà poi “reggere” la tensione per altre 700 pagine, se subito si sparano i fuochi d’artificio. E infatti si procede con un accumulo impressionante di misteri, complotti e fatti mai spiegati che, alla fine, più che incuriosire stancano alla grande. A un certo punto ho smesso di cercare di capire, i personaggi prendevano decisioni e giungevano a conclusioni secondo me a casaccio (è vero che nel caso di Collins dovrebbe dare l’idea di una mente sempre più obnubilata dall’oppio e dal laudano, ma ‘sti cavoli, per il lettore è sfiancante), e allora mi sono detta amen, arriviamo alla fine.
Altro commento per me incredibile: “La Londra del 1860 è resa in modo splendido” (The Guardian). Ma per favore! Dove sta la Londra del 1860, qui stiamo tutto il tempo o a casa di Collins, o a casa di Dickens, o a passeggio per la campagna presso Rochester, o (al massimo) a teatro… ah sì, ogni tanto andiamo in qualche non meglio specificato o descritto “quartiere malfamato” che rimane sempre un indistinto ammasso di vicoli e case buie, non sembra mai una ricostruzione convincente e “viva” (e tra l’altro è sempre lo stesso manipolo di personaggi che si parla addosso, quindi neanche ci “immergiamo” nel milieu socio-culturale londinese o fra gli strati più umili della popolazione).
Per 800 e passa pagine siamo costretti a seguire la voce narrante, che come ho detto è Wilkie Collins, grande amico di Dickens. Naturalmente all’amicizia si aggiunge anche una buona dose di rivalità/invidia/ammirazione, in un intreccio complesso che poteva essere anche interessante. Purtroppo Collins riesce odioso (alla faccia dell’amico, praticamente a ogni riga c’è una cattiveria su Dickens), e probabilmente non si tratta di gusti miei ma sicuramente era precisa intenzione dell’autore renderlo odioso agli occhi del lettore (da un certo punto in poi diviene evidente che ci troviamo di fronte a un narratore assai inaffidabile), fatto sta che 832 PAGINE SEMPRE IN COMPAGNIA DI UN PERSONAGGIO ODIOSO sono una tortura inimmaginabile.
Il paradosso è che le parti all’apparenza più “noiose”, quando si parlava dei romanzi scritti o da scrivere dei 2 autori amici/rivali, delle loro tecniche narrative, dei giudizi vicendevoli sui loro romanzi (la scena migliore del libro è quando Dickens fa a pezzi il bestseller del momento di Collins, La pietra di luna), dell’abilità “pubblicitaria” di Dickens e della novità e gli effetti dei suoi tour di letture (quantunque, alla cinquantesima volta che veniva descritto uno di questi spettacoli di Dickens, cominciavo a stufarmi), erano di gran lunga più avvincenti della paccottiglia fantastica senza né capo né coda su Drood e i riti egizi e il mesmerismo e gli scarafaggi nel cervello (che schifo) e bla bla (che poi it was all a dream, naturalmente). Pure un “normale” romanzo storico sui travagli familiari di Dickens sarebbe stato meglio di questo (sebbene svariati pezzi apparissero proprio come “inserti saggistici” messi lì, con innumerevoli aneddoti biografici). Interessante anche cercare di cogliere qua e là alcuni (rari) dettagli presi da The Mystery of Edwin Drood e “fusi” nella trama del libro.
Sarei anche stata disposta a dare 2 stelle per questi ultimi aspetti, ma l’epilogo (l’ultimo paio di capitoli) mi ha fatto abbassare il voto.
Dan Simmons, Drood (trad. Anna Tagliavini), voto = 1,5/5