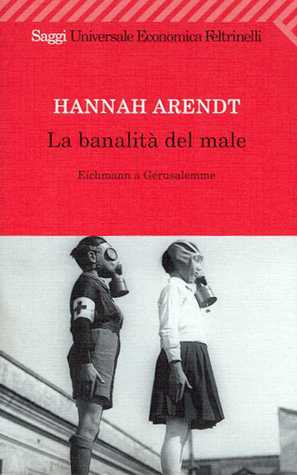Il libro per il Giorno della Memoria 2015, scoperto esaminando le ultime novità in uscita sul sito della Einaudi: un libro bellissimo, cui non saprò fare giustizia.
Il libro per il Giorno della Memoria 2015, scoperto esaminando le ultime novità in uscita sul sito della Einaudi: un libro bellissimo, cui non saprò fare giustizia.
Estate 1944. A Theresienstadt, il “lager modello”, dove sono rinchiusi gli ebrei più eminenti, gli artisti, le personalità di riguardo, il prigioniero Kurt Gerron viene convocato dal comandante del campo, Karl Rahm. Il berlinese Kurt Gerron era stato un celebre attore teatrale e cinematografico: partito dal cabaret, il grande successo era arrivato grazie all’Opera da tre soldi di Brecht, in cui cantava la famosa canzone d’apertura, quella di Mackie Messer (qui la potete ascoltare nella versione in cui la conobbi io, cantata da Ute Lemper), poi vennero i film, e in particolare L’angelo azzurro, di von Sternberg, con Emil Jannings e Marlene Dietrich, poi aveva scoperto la passione per la regia, firmando vari film di successo.
Ora però non è più nulla, e anzi la sua vita ormai conta così poco che si sente fare questa proposta (proposta? Si fa per dire, in realtà un ordine…) terribile: perché non gira un bel film di propaganda che mostri al mondo come è bella la vita nel lager, come fervono le attività produttive, come sia vasta e apprezzata l’offerta di attività culturali, ricreative e sportive disponibili? Per tre giorni Gerron si tormenta, chiedendosi se debba tradire le sue origini, i suoi compagni di sventura, la sua arte, e rendersi complice dei suoi aguzzini. E, accanto a queste angosciose riflessioni, in parallelo si snoda nella sua memoria tutta la sua vita, la famiglia, i genitori distanti e così rigidamente “tedeschi”, ma comunque amatissimi, oggi anch’essi deportati, chissà dove, sicuramente uccisi; la scoperta, da bambino, grazie al nonno materno, del mondo meraviglioso del teatro e del cinema, divenuto la vera vocazione di tutta la sua vita; l’esperienza traumatica della guerra, con i giovani della sua generazione andati (o spinti) entusiasticamente incontro a un inferno terribile, esperienza da cui esce col corpo lacerato e il carattere per sempre cambiato; l’incontro con Olga, l’amore, il matrimonio; il debutto e i primi successi, nell’atmosfera irripetibile della Berlino dei primi anni Venti, Brecht, i colleghi con le loro storie, gelosie, rivalità, grandezze e piccolezze… Tutte cose che un tempo erano la sua vita, che erano per lui il centro del mondo, mentre nel frattempo… Nel frattempo, nell’indifferenza di tutti, sotto lo sguardo fra il divertito e lo sprezzante di Gerron e degli altri che, come lui, la sapevano più lunga di tutti, la Germania si consegnava ai nazisti. Fino a che, il 1º aprile 1933, l’inizio della fine: è negli studi dell’UFA, sta girando, come tutti i giorni, una scena del suo ultimo film, quando, l’annuncio: tutti gli ebrei lascino immediatamente gli studi. Anni di esilio tra l’Austria, la Francia e l’Olanda, con la moglie e i vecchi genitori al seguito, a fare affidamento sugli aiuti dei colleghi che hanno avuto più successo di lui, più fortunati o più previdenti. Ma sempre, sotto sotto, il pensiero che certe cose non possano accadere sul serio… perché, chi potrebbe mai pensare…? E, naturalmente, tornano alla memoria tutte le occasioni di fuggire sprecate, perché… perché chi avrebbe immaginato che…? Tutte le volte che la sua storia personale avrebbe potuto prendere una piega diversa, se avesse preso la decisione giusta al momento giusto, mentre invece il tempo, gli spazi, le opportunità, la libertà poco a poco si assottigliano sempre di più, da Berlino all’Austria, a Parigi, assieme ai tanti altri esuli tedeschi, all’Olanda, a Westerbrok, e poi… eccoci, Theresienstadt, uno squallido tugurio sopra le latrine, la fame che ormai non ti abbandona più, senza essere riusciti a fermare l’onda, senza aver capito che l’onda non si sarebbe più fermata, e dopo c’è solo il trasporto a est, i treni che partono regolarmente, Auschwitz. E, accanto ai ricordi, l’interrogativo sempre più angoscioso: girare il film o no? Ma, in realtà, sta solo cercando di ingannare se stesso, perché ha veramente una scelta? Il film lo girerà, perché è un ordine, perché non vuole morire, non vuole essere deportato e soprattutto non vuole che la moglie Olga venga deportata con lui per colpa sua.
E così, iniziano le riprese, con gli altri internati del lager a fare da attori/comparse, tra scene surreali di raccolte di pomodori, divertenti bagni nel fiume, deliziosi quadretti con famiglie felici a cena. Una montatura allucinante, ma, per quanto possa sembrare paradossale, alla fine a quel lavoro Gerron finisce per dedicarsi anima e corpo, vuole farlo bene, sa di poterlo fare bene. Perché più si renderà utile e si dimostrerà bravo, più aumentano le possibilità per lui e Olga di non essere deportati, certo. Perché, allo stesso modo, può cercare di “proteggere” i suoi collaboratori, utili alla realizzazione del film e quindi anche loro esclusi, almeno temporaneamente, dal trasporto, certo. E però anche perché fare film è ciò che è, ciò che ama, e allora, finché non gli avranno portato via anche questo, avrà conservato un margine di libertà, così come l’anziano professore di filosofia che ora, nel lager, viene utilizzato come guardiano dei cessi, eppure non ha rinunciato al gusto della dialettica.
Come avvisa l’autore, questo è un romanzo e molte cose nel libro sono inventate o sviluppate liberamente a partire da fatti storici. Alcune cose sono assolutamente vere, però: la prima è che Kurt e Olga Gerron vennero deportati da Theresienstadt ad Auschwitz e lì vennero uccisi, subito dopo l’arrivo, nelle camere a gas nell’ottobre 1944, poco tempo prima che il lager cessasse l’attività. La seconda è che il film propagandistico sulla “città modello” di Theresienstadt che Gerron fu costretto a girare è terribilmente vero: non servì a Gerron a salvarsi la vita (o forse anzi fu proprio perché vi aveva lavorato che venne eliminato) e non fu lui a montarlo, e l’andamento della guerra nel 1944-1945, con la sconfitta sempre più imminente per la Germania, impedì che venisse mai effettivamente mostrato. Oggi rimangono solo alcuni spezzoni: ecco la voce su Wikipedia e qui si possono vedere alcuni minuti (non è il titolo ufficiale, ma il film finì per essere noto soprattutto col titolo Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, “il Führer regala agli ebrei una città”, da cui il titolo dell’edizione italiana del libro, Un regalo del Führer, più efficace per una volta dell’originale, Gerron).
Charles Lewinsky, Un regalo del Führer (trad. Valentina Tortelli), voto = 4/5
 Questo libro aveva, fino a qualche mese fa, un curioso “primato”: il più “iniziato e subito abbandonato”. Avrò provato a cominciarlo almeno tre volte in passato, e sempre mi sono bloccata più o meno a pagina 3. Non che ci fosse qualcosa di terribilmente ripugnante a pagina 3, solo che, vai a capire, mi si chiudevano gli occhi. Ancora una volta è giunto “in soccorso” il gioco della Parola del mese di Goodreads Italia, che a giugno proponeva la parola “sogno”; in realtà è un non-gioco, non si vince nulla, ma per me e per altri è un modo come un altro per scegliere il prossimo libro da leggere e magari, appunto, smaltire cumuli e cumuli di “arretrati”.
Questo libro aveva, fino a qualche mese fa, un curioso “primato”: il più “iniziato e subito abbandonato”. Avrò provato a cominciarlo almeno tre volte in passato, e sempre mi sono bloccata più o meno a pagina 3. Non che ci fosse qualcosa di terribilmente ripugnante a pagina 3, solo che, vai a capire, mi si chiudevano gli occhi. Ancora una volta è giunto “in soccorso” il gioco della Parola del mese di Goodreads Italia, che a giugno proponeva la parola “sogno”; in realtà è un non-gioco, non si vince nulla, ma per me e per altri è un modo come un altro per scegliere il prossimo libro da leggere e magari, appunto, smaltire cumuli e cumuli di “arretrati”.